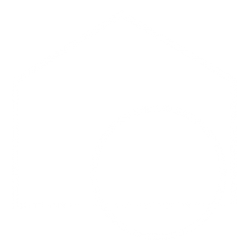Le interviste impossibili. Intervista all’architetto Leon Battista Alberti (1404-1472)
D: Buongiorno architetto Alberti, lei è considerato dalla critica e – in un certo qual modo dalla stessa opinione pubblica – l’architetto più radicale della sua generazione, noto per le sue prese di posizione estreme, quando non – ci permetta di dire – irritanti. Ci interesserebbe conoscere la sua opinione, proprio per queste ragioni e alla luce delle svariate e definitive prese di posizione e ricette espresse da suoi esimi colleghi in quest’ultimo periodo, sulla questione che potremo sintetizzare così: “lo stato dell’architettura in Italia durante e dopo il Coronavirus”. Innanzitutto qual è l’aspetto che ritiene emblematico di questa vicenda?
R: In primo luogo – direi – l’immagine delle città vuote. Ci sono state servite, con contorno di commenti edificanti e attoniti sulla bellezza del Paese, viste di luoghi e spazi urbani deserti: Piazza del Duomo a Milano, con il selciato lucido e netto come non mai e in primo piano un figurante in tenuta antivirus che spruzza con una lancia un liquido in un’azione definita di sanificazione; o Piazza San Marco a Venezia, sgombra di turisti e piccioni (!); o Piazza del Plebiscito, a Napoli, senza auto in sosta. Mi soffermo sulle piazze perché l’Italia è questa e perché proprio le piazze d’Italia così decantate (purificate) hanno finalmente portato a compimento il sogno metafisico di De Chirico che le aveva rappresentate così: solitarie, svuotate di persone e cose, le ombre lunghe di presenze assenti, immobili nell’attesa del manifestarsi di un evento (heideggeriano, mi figuro), mentre oggi l’evento si è già manifestato ed è proprio questo il risultato cui ci ha portato e le ombre non sono poi così lunghe data la stagione. Risultato che suscita immediatamente in me questa sintesi: siamo in troppi.
D: Ma non le risulta che ormai da quattro-cinque anni si stia registrando nel nostro paese un inesorabile calo della popolazione, non compensato dai flussi migratori, con tassi di fecondità in declino, ecc., tanto che le maggiori autorità civili e morali hanno preso posizione invitando i cittadini a darsi da fare per contrastare questa tendenza?
R: Paradossalmente questa epidemia si è fatta carico di mettere in evidenza una serie di fenomeni latenti nel corpo sociale e nell’architettura con una tale persuasività che mi ha fatto più volte pensare che ce la siamo meritata, o che, per qualche verso, ce la dovevamo aspettare, o, forse, più ancora, ce la stavamo aspettando. In effetti l’adozione della strategia del social distancing ci ha segnalato in modo irrevocabile il problema della densità di popolazione nei centri urbani (che è di circa 6300 abitanti/kmq), e ci ha dimostrato che l’invecchiamento della popolazione (sono il 23% gli ultrasessantacinquenni sul totale) comporta l’isolamento di parte di questa fascia di età in luoghi e strutture che per le loro regole e con la loro inadeguatezza si sono fatti carico di abbassare la media. Ma oltre a ciò le grandi piazze vuote ci mettono fisicamente sotto gli occhi il paradosso dell’estensione infinita dello spazio esterno ai nostri corpi, alle nostre coscienze che si pone in totale contrasto con l’estensione ridotta, infima del nostro stare nel mondo, del nostro risiedere nel mondo.
D: Si spieghi meglio.
R: I livelli del problema sono due. Da un lato – sul piano fisico – abbiamo a disposizione uno spazio esteso, rappresentato, appunto, dalle piazze vuote ritenute finora spazio privilegiato, della libertà, della socialità, della comunicazione interpersonale, dall’altro esercitiamo le nostre pratiche quotidiane all’interno delle nostre case, celle, loculi in cui decliniamo un altro livello di libertà, quello delle reti e della comunicazione digitale. Questa epidemia ha compresso in modo sorprendente queste libertà, con l’illusione dello smart working e con l’incitamento della pubblicità ad acquistare decisamente prodotti sui quali si sono riconvertite le case di moda (mascherine reinterpretate come occhiali-visiera), le aziende produttrici di cibi per cani e gatti (mai così attive come nel corso del lockdown). Ora, il fatto sorprendente è che, dati questi presupposti, lo spazio dell’abitare non è misurabile se non commercialmente (qualcuno ha proposto di innalzare a 60 mq. lo standard minimo per le abitazioni!), perché l’abitazione è già di per sé contratta e si esprime in schermi, monitor, tablet, le cui unità di misura sono notoriamente i pollici.
D: Va bene, ma noi tutti abbiamo sotto gli occhi le immagini di terrazzi e balconi di condomini cittadini popolati di gente che discute, suona, canta, diffonde cose, mette in scena performances di ogni tipo!
R: Già, e questa sembrerebbe una dimostrazione della volontà di mettersi in relazione, di interagire, di comunicare col prossimo (anche con l’odiato vicino, nemico giurato di tante riunioni condominiali), mentre in realtà non è altro che una forma di esibizionismo temporaneo, una testimonianza di vitalità, in attesa di ritornare al divano, davanti alla TV o al monitor del PC, e di introdurre per tale via ospiti solo illusoriamente amichevoli.
D: Ma non le sembra invece, architetto Alberti, che tutto ciò sia la denuncia implicita dell’esiguità – nell’abitare – degli spazi comuni, ma anche degli spazi aperti, della mancanza di verde, ossia, in definitiva, il desiderio di un più diretto e vitale rapporto con la natura?
R: Be’ qui siamo andati un po’ troppo avanti. Cerchiamo di mettere ordine nelle questioni e ripartiamo dal concetto di social distancing. Per tutte le ragioni dette dovremmo parlare piuttosto di physical distancing visto che la distanza auspicata dalle norme di sicurezza è piuttosto traducibile in misure, mentre la separazione delle persone non implica la disconnessione che si perpetua comunque mediante i canali e le protesi mediatiche. E poi quanto sia arbitraria l’unità di misura proposta lo dimostra questo esempio: la municipalità della Contea di Leon, in Florida, ha affisso e fatto circolare presso la popolazione un manifesto in cui si suggerisce alle persone di mantenere una dall’altra la distanza di un alligatore! A ciascuno il suo metro e i propri incubi! Ora, ho sentito che da qualche parte sono state avanzate ipotesi di ridisegno e riprogettazione degli spazi abitativi, che puntino soprattutto a comprendere nell’abitazione collettiva nuove funzioni come l’infermeria, la palestra, spazi per attività di comunità, ecc. E mi sembra di sognare, perché è da ormai un secolo che si è posta la questione del (mancato) rapporto tra casa e servizi e tutti i tentativi di superare questo gap si sono scontrati con le crudeli logiche del mercato e con la volontà individuale di mantenersi socialmente e fisicamente distanti dal vicino. Non parliamo poi dei cosiddetti spazi aperti condominiali che si sono materializzati in balconi e terrazzini, prodotti dai regolamenti edilizi che penalizzano (monetizzano) le logge e favoriscono gratuitamente sporti ed aggetti (non superiori a ml. 1.50: misura del tutto futile funzionalmente se non per il ricovero della spazzatura e della lettiera del gatto). E veniamo, infine, alla questione del verde e della natura. Vediamo bene che oggi la natura va per la maggiore. Parole come ecologico, campagna, vecchi borghi sono pronunciate da tutti con grande voluttà, da molti miei colleghi. L’auspicio è: via dalle città, dalla folla, dall’ammassamento; nei piccoli centri, nei villaggi rurali (magari dell’Appennino) è il nostro futuro; oppure: la campagna non deve essere un lusso (seconda casa), ma diventare un’alternativa alla portata di tutti. Ma se devo essere schietto dirò questo: la natura per l’architettura non esiste. Per l’architettura la natura è sempre un fattore artificiale, qualcosa che può essere affrontato solo se in forma artificiale, circostanziale, addomesticata. La natura, di per sé, è indifferente e subisce l’azione dell’uomo, salvo poi a reagire se oltrepassato il limite e a riprendersi ogni spazio, se liberato dall’occupazione antropica. Ma anche in questo caso devo ripetere che tante lodevoli e apprezzabili istanze si scontrano con una sorta di Convitato di Pietra che è quello dei Grandi Numeri, che sul piano demografico mi spingono a ripetere: siamo in troppi. Quel che mi sembra di capire, concludendo, è che questa emergenza del Covid-19, con l’introduzione di nuovi fenomeni e concetti e linguaggi come social distancing, smartworking, smartlearning, oppure isodesk, CovideoParty (una festa-con-video virtuale), quando non boomer remover (il Covid-19 inteso come dispositivo di rimozione della popolazione nata nel periodo del boom – 1946/1964), ecc. si è configurata come potente fattore di ulteriore infrazione di ogni forma di unitarietà, di interezza dei concetti, dello spazio, dei comportamenti per favorire viepiù la dispersione, la moltiplicazione delle prospettive (confermando ulteriormente l’intuizione benjaminiana del frammento), tanto che ogni discorso può prendere vita attraverso il semplice montaggio di pezzi, di scene staccate, realizzate in luoghi separati, da soggetti diversi, anche animati da intenzioni diverse, per poi essere montate in un video. E’ il mondo del clip.