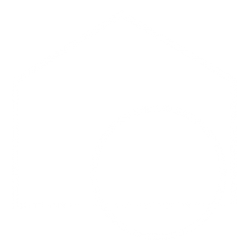Architettura negata
In questo terribile momento storico, momento di grandi paure e ripensamenti, si concretizza, in modo molto evidente, la sempre temuta realtà dell’immobilismo collettivo a favore dello scatenarsi dell’incontrollato e incontrollabile movimento individuale, che, come il sonno della ragione, può generare mostri. Si assiste, impotenti e annichiliti a un annullamento progressivo e quotidiano del vivere civile e dello scambio, fisico e verbale, pur con tutti i conflitti (necessari) che questo genera e ha sempre generato. La privazione del contatto tra persone, sia sul piano fisico sia su quello della comunicazione verbale, causato dall’imperativo del silenzio, imposto dalle nuove norme che regolano la diffusione della pandemia, contribuisce sia all’isolamento sia alla degenerazione del pensiero individuale che si serve, dall’inizio dei tempi, di ‘contaminazioni necessarie’ tra le varie e diverse forme di pensiero e di azione. E’ in corso la ricostruzione, mai abbandonata, della mitica torre di Babele, che continua a replicarsi in mille luoghi e forme, per poi cadere miseramente. Sarà questa la nostra ‘rinascita’? Lo stato sociale verrà ricostruito dopo la pandemia? Dovrebbe essere questo l’imperativo categorico oggi in Italia. In attesa, invece, viene chiesta la ‘distanza sociale’, identificata in modo erroneo e terribile con la ‘distanza fisica’ per impedire la diffusione del virus, anche se la ‘distanza sociale’ vera esiste ed esisterà sempre più consistente! Quando si chiede a tutti di ‘stare a casa’ si impone una reclusione a chi ha la casa piccola, una disperazione a chi non ce l’ha e la ‘felicità’ a chi abita grandi spazi sia abitativi che verdi! Vivere la pandemia, ancora una volta, significa risaltare le differenze e le distanze, appunto, sociali! Ora l’architettura deve ripensare al suo nuovo ruolo sia in Italia sia nel mondo. Bisogna allontanare l’idea delle città pensate in assenza della dimensione umana, utopie dannose e impraticabili! Sono necessarie visioni di un buon abitare, frutto di quel ‘buon governo’ che già nel 1400 si ipotizzava potesse guidare un uomo dilaniato e sospeso, immerso in una bolla di dannose e false positività annunciate. Andrà tutto bene, si dice, ma sarà molto dura una possibile rinascita! Non si potrà mai dimenticare che questo tempo ha deportato in massa gli anziani per farli morire nei ‘lager’ chiamati ‘case di riposo’, pesantemente ‘contaminati’ da solitudini, distruzioni e disperazioni, oltre che dal corona virus. Il ‘quid tum’ di Leon Battista Alberti si ripropone con sempre maggior forza; è il ‘che fare adesso’ che ci impone una riflessione che anticipi l’azione, con l’unico obiettivo della salvaguardia della vita in tutte le sue forme, e di quella dell’uomo, procurandogli una dignità dell’abitare che solo l’architettura, dialogante con tutte le forme di poteri, gli può dare. Se analizziamo le due parole: ricerca e cura, isolandole dal normale contesto della frase in cui sono inserite, diventano, come dice Paul Valèry, “(…) quasi per magia ingombranti, opponendo una strana resistenza. (…) Eccole qui, tutte sole, ‘afferrate per le ali’, ci fanno credere che le funzioni che hanno coperto non esauriscono affatto il senso di cui sono depositarie. Prima non erano che un mezzo, mentre ora sono diventate un fine: oggetto di una spaventosa sollecitazione filosofica. Si trasformano in enigma, in un baratro, in strumento di tortura della mente…”. Ricerca e cura, che sono straordinariamente importanti per ogni cosa si possa intraprendere nel proprio percorso di vita, se ‘prese per le ali’ possono far ulteriormente riflettere sul loro più autentico significato. Ri-cerca è il ‘cercare ancora’, mai pago, con un continuo lavoro di indagine eseguito in modo sistematico e non casuale, monitorando tutte le possibili variazioni per acquisire nuove conoscenze relative all’oggetto di analisi; che sia scientifica e/o tecnica fornisce un apporto decisivo all’approfondimento conoscitivo. Cura è osservazione, attenzione, presenza. Il termine greco kedos, da cui deriva, porta a riflettere su un altro termine, a-kedos, cioè accidia, che è mancanza di cura. Ecco allora già tracciata una strada, interessante e ingombrante, per l’analisi attenta, attiva e applicata delle due parole. Nella mia professione, che è quella di architetto, queste due parole divengono ‘essenza’, ogni volta che intraprendo una qualsiasi idea di progetto, nel senso di pro-iectum, di ‘gettare avanti’ una proposta, oltre che me stessa. Questa professione non si serve della ricerca, è ricerca, nel senso che non può mai prescindere dal rapporto con fattori legati a variabili che influenzano in modo decisivo il risultato: il luogo con le sue ‘presenze’, sia naturali che ‘artificiali’; le persone che lo abitano con le loro strutture aggregative, le loro culture e le loro aspettative nei confronti di qualsiasi modificazione (minima o massima che la nuova costruzione propone) dell’ambiente in cui sono abituati a vivere; la scelta dei materiali e delle necessarie relazioni che sono chiamati ad instaurare con il luogo, la luce, gli utenti e con la tecnica e le ultime scoperte, e, assolutamente di primaria importanza la relazione che ogni scelta progettuale deve instaurare con il proprio tempo e con la storia. Heidegger, interrogandosi su: chi è l’uomo, si risponde: “è colui che è nel mondo, Hannah Arendt, dichiara invece “noi siamo del mondo, e non semplicemente in esso”. Ed è proprio questa consapevolezza di essere del mondo, che fa nascere e mostra, come dice Simone Weil, un forte e ben radicato presentimento di eternità, che caratterizza ogni individuo che vive ‘sotto il sole’, e, secondo me, si manifesta in tre modi:
attraverso la relazione con l’altro,
attraverso l’esercizio dell’arte,
attraverso la costruzione del pensiero.
Sono tre modalità che, se percorse sapendole riconoscere, lasciano sempre e comunque tracce consistenti nel breve e frantumato cammino che ci troviamo a fare. L’esercizio dell’architettura contiene le tre modalità, come quello della poesia. Holderlin dichiara (in un suo famoso saggio sull’abitare) che “il poetare è la capacità fondamentale dell’abitare umano”, in quanto vero costruireè quello che prende, misura e mette insieme i materiali come la poesia fa con le parole: fondando ciò che è destinato a durare, secondo l’altra sentenza di Holderlin (quello che dura lo fondano i poeti), che Heidegger sviluppò in una conferenza romana del 1937. Già Gropius in architettura integrata, Luigi Einaudi negli anni 30 dello scorso secolo, rivendicano il paesaggio e la sua bellezza sul piano poetico contro ‘le escrescenze delle gigantesche città’, così come Rilke, il quale dichiarò che “la bellezza è il senso di tutto l’essere”, scendendo in campo a difendere la città di Anfione, contro la devastante aggressività di Prometeo. La poesia e l’architettura, con il loro vero costruirecercano forse ancora la città del logos, intesa come città dell’uomo verticale, in cui ogni abitante può ridestare in sé la virtù meditando sul suo essere, e ritrovando, nell’abitare, la leggerezza per la costruzione della sua interiorità e di tutto ciò che deve continuare a costruire finchè gli è dato vivere .Non possiamo assolutamente dimenticare che attraverso l’edificazione architettonica, indispensabile e responsabile strumento di costruzione di identità individuali e di strutture sociali, si può avere anche il polso del governo di un’intera comunità: città, nazione o villaggio globale che dir si voglia. Le opere di un grande architetto come Mies van der Rohe si possono tranquillamente definire icone fortemente rappresentative della modernità; qualitativamente ineccepibili, sono destinante a durare nel tempo e dialogano contemporaneamente con le grandi opere del passato. Ma è solo questo ciò che fa diventare i prodotti di questa disciplina così importanti per la condizione umana e il buon equilibrio del vivere? Oppure il loro essere decisamente presenti in un complesso sistema di relazioni,al momento della loro nascita, non li ha forse cristallizzati come eventi che modificano comunque e sempre – nel senso di ininterrotta continuità temporale – il contesto fisico, umano e sociale in cui sono inseriti? Parlo di eventi e non semplicemente di cose costruite, proprio perché credo veramente che l’architettura, fintanto che esiste, voluta o no dal consenso collettivo, possa creare grandi alterazioni nel vivere degli uomini di tutti i tempi. Ma organizzare geometricamente lo spazio significa, individuandone la misura, inserirlo nel tempo dell’uomo, che non è il tempo lineare dell’invecchiamento e della morte delle cose, ma il tempo disastroso che si riprende le cose, proponendosi continuamente nella sua valenza duplice di costruzione e distruzione. È interessante riflettere sul termine morfologia coniato da Goethe nel 1796, con il significato di «studio e descrizione della forma», ma che letteralmente significa «studio della formazione della parola», che, non a caso, prende corpo, si costruisce, nell’agorà, luogo in cui si parla, in cui prende forma la relazione tra gli uomini nelle cose e tra le cose. Apollo, il dio che organizza lo spazio, definiva il modo in cui gli uomini dovevano vivere insieme, non solo la forma delle loro città. Costruire, dunque, grazie alla parola, il luogo in cui, parlando, ci s’intende, e, contemporaneamente, lo stato di cose che ne permetta la definizione, regolamentazione e moltiplicazione. Si può allora dedurre che le relazioni tra cose non esistono se non si presuppone la parola come inizio; ovvero ogni relazione diventa tale solo grazie alla nominazione che il linguaggio organizza su di essa. La parola è l’unico principio d’individuazione tra le cose, che esistono proprio grazie alla loro morte, alla morte del loro perfetto isolamento, che le costituisce nella loro identità di cose uniche e separate le une dalle altre all’interno di una supponente cosmica armonia o disarmonia, che non è dato conoscere. Proprio l’architettura, il grande libro di pietra, ha permesso la conoscibilità della parola che costruisce; mentre la relazione tra le parole, dopo la morte delle cose, si è fatta cosa. L’architettura non può che essere struttura di relazione, essendo, per definizione, linguaggio, e per convenzione, artificio, fondato su una sommatoria di regole. La fattibilità del fatto passa attraverso la sua riconoscibilità interpretativa, passa attraverso il dire la sua possibilità di esistere prima in forma di pensiero, poi in forma di parola, infine in forma formata, matericamente organizzata. Enzo Bianchi, nel suo libro ‘L’altro siamo noi’, dichiara, con preoccupazione, che viviamo in un’epoca in cui si può ipotizzare ‘la morte del prossimo’, perché si esprime solidarietà generica con chi è lontano, mai con l’altro accanto a noi. La ricostruzione deve ripartire dalla consapevolezza di queste distruzioni e di queste morti, non da recuperi ideali e nostalgici di individui risanati eticamente o di concetti di città programmabili a priori: concetti che non sono più pensabili, visto il sostanziale sovvertimento avvenuto nel rapporto tra artificio e natura, e tra l’uomo e il suo simile. La ricostruzione può partire dunque da ogni nucleo limitato, all’interno del quale si presenti, sorga un problema; deve partire dal già dato, dai centri storici, pieni di memorie con cui dialogare; dalle periferie, sulle quali concentrare una serie di possibili «ristrutturazioni», da tutto ciò che preesiste e che va rifondato e riformato, sapendo bene come dice Jabès, (citato da E.Bianchi) che “lo straniero ti permette di essere te stesso, facendo di te uno straniero (…) e che la distanza che ci separa dallo straniero è quella stessa che ci separa da noi”; e, che questa distanza, aggiunge Enzo Bianchi, possa essere ponte o baratro, dipende solo da noi. Architettura quindi, ribadisco, come struttura di relazione, come lavoro dentro le cose, gran parte delle quali volute dal moderno sotto forma di bricolage, di apologetica del frammento e della contaminazione dei generi. Il volto duplice del moderno ha però prodotto anche l’idea del nuovo, del mai pensato prima, il costruttivismo formale come sfida, nato con una grossa referenzialità progettuale, miseramente caduta quando si è fatta strada la convinzione che, in realtà, non sarebbe stato possibile inventare nulla di veramente nuovo, per cui la grande tensione costruttivista e razionalista si è trasformata nello smontare e rimontare senza posa le forme prodotte in altri tempi, dando origine a bricolages senz’anima e senza destino. «Chi oggi vuole restituire la parola all’architettura è quindi costretto a ricorrere a materiali svuotati di senso: è costretto a ridurre al grado zero ogni ideologia, ogni sogno di funzione sociale, ogni residuo utopico. Nelle sue mani, i materiali della tradizione architettonica moderna, vengono di colpo ridotti a enigmatici lacerti, a muti segnali di cui si è perso il codice, conficcati casualmente nel deserto della storia. A loro modo, gli architetti che dalla fine degli anni ’50 a oggi hanno tentato di ricostruire un universo di discorsi per la loro disciplina si sono sentiti in dovere di ricorrere a una nuova morale del contegno. Oggi, allora, è necessario assumere come unica realtà questo duplice volto del moderno, per riuscire a leggere il sostanziale rovesciamento avvenuto nei modi della progettazione, in quanto i mezzi si sono trasformati in fini. Questo per dire che sarebbe non solo utopico, ma folle, cercare la strada dell’autenticità e dell’unicità attraverso la produzione architettonico-urbanistica. Per arginare la deriva della città diffusa può essere concepito e applicato solo un pensiero progettuale consapevole dei propri limiti: limiti intesi in senso stretto, procedurale, applicativo, non moralistico; limiti intesi come strumenti atti a operare nello specifico che presenta sempre, contemporaneamente, tensione allo sradicamento e all’appartenenza, all’omogeneo e al disgregato. La progettazione architettonico-urbanistica non può che inserirsi in questo spazio obliquo, profondissimo, tra gli opposti in lotta e compresenti.